L’8 aprile 1990 la rete televisiva americana ABC mandò in onda la prima puntata di Twin Peaks. Fu una rivoluzione: è ragionevole dire che nella storia del piccolo schermo esiste un prima e un dopo Twin Peaks.
Sono molti i modi in cui si potrebbe raccontare lo show di David Lynch e Mark Frost e la sua enorme influenza, rintracciabile ancora oggi nelle produzioni televisive più avanzate. Qui ho scelto di farlo attorno a quattro episodi iconici delle due stagioni storiche.
I quattro episodi che – si può dire senza esagerare, per una volta – cambiarono la storia della televisione.
Quattro episodi, non per caso diretti tutti da Lynch, attraverso cui esploreremo altrettante tesi sulla rilevanza storica di questa serie, e sui modi in cui ha cambiato per sempre il panorama del piccolo schermo. Ecco le tesi: la tv poteva essere complessa; poteva cessare di essere rassicurante; poteva forzare i limiti del piccolo schermo, avvicinandolo al cinema; poteva ambire ad essere un medium pienamente artistico.
La stessa riflessione è stata affrontata in questa puntata del podcast. Mentre la serie completa in Italia è oggi disponibile su Paramount+.
L’intero SPECIALE TWIN PEAKS è consultabile qui, con i suoi diversi contenuti. E un omaggio a Lynch.
Benvenuti nella “complex tv”: Northwest Passage (episodio pilota).
Un’alba brumosa. Un pescatore, sulla riva del lago, nota qualcosa fuori posto. È un corpo, avvolto nella plastica: quello della reginetta del liceo, Laura Palmer. Se a chi ha visto Twin Peaks si chiedesse: “come comincia?”, questa è la risposta più probabile.
La serie in realtà inizia con una lunghissima sigla di testa. Sull’indimenticabile tema musicale di Angelo Badalamenti vediamo, in una fotografia dai toni seppia, immagini di una cittadina del nord-ovest americano: montagne, boschi, la cascata, il fiume, la segheria.
L’attacco non è casuale: col suo ritmo dilatato, il tono sognante e surreale, predispone alla visione di una storia in cui fin dalle prime battute il vero protagonista sembra il mistero. Chi la vide allora ricorda ancora la sensazione che si stesse assistendo al principio di qualcosa che non assomigliava a nulla di quello che si era visto fin lì.

Era il 1990: la TV era ancora “the idiot box”, la scatola stupida. Gli autori seri, così come gli attori seri, lavoravano solo per il cinema. Il piccolo schermo era popolato di soap opera interminabili, melodrammi, telefilm d’azione o d’avventura, sit-comedy, e un’infinità di polizieschi con i loro cliché altamente codificati. In altre parole, puro intrattenimento, relax senza troppi pensieri (per chi avesse voglia di approfondire, il testo di riferimento è Complex Tv di Jason Mittell, pubblicato in Italia nel 2017 da minimum fax).
In questo panorama arrivò David Lynch (qui il nostro ritratto-omaggio dopo la morte), che aveva debuttato al cinema con un film impossibile, Eraserhead (1977), divenuto in breve tempo oggetto di devozione. E che poi durante gli anni ‘80 era riuscito a conquistare prima il pubblico, con Elephant Man (1980), e quindi la critica, con Blue Velvet (1986). Insomma, un autore vero, portatore di una poetica particolarissima e tutt’altro che commerciale.
Assieme a Mark Frost, che si era fatto le ossa in tv con un poliziesco innovativo come Hill Street Blues (1982-1985), convinse la rete ABC a produrre una miniserie investigativa, incentrata sull’indagine dell’agente dell’FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) attorno all’omicidio della giovane bellezza locale Laura Palmer (Sheryl Lee), nella cittadina immaginaria di Twin Peaks.
Fu uno shock globale, dagli Stati Uniti al Giappone fino a casa nostra (qui sotto l’eccezionale video di Mike Bongiorno che presenta Twin Peaks al pubblico di Canale 5: “pare che sia addirittura superiore a Dallas“).
E una profonda rivoluzione. Per una serie di ragioni. Una fu chiara fin dall’inizio: l’innovazione visiva e stilistica, che forzava gli spazi angusti del piccolo schermo avvicinandolo a un’esperienza più cinematografica. Altre emersero col procedere delle puntate.
L’ibridazione dei generi, oggi frequentissima, non era cosa a cui si fosse allora abituati. Twin Peaks ne mescola diversi: il drama, il thriller, l’investigativo. Ma anche il comico. L’horror sovrannaturale. Il melodramma.
Rispetto allo standard del telefilm, allora imperante per i prodotti “gialli”, lo show di Lynch e Frost sviluppa un originalissimo, ampio e articolato arco narrativo. Eravamo in un’epoca in cui se di una serie perdevi una puntata, o cinque, poco male: l’arco narrativo globale era nullo, o ridottissimo. In Twin Peaks, invece, ogni episodio porta altre domande, e saltare una puntata significa perdere porzioni cruciali del plot. La serie sfida lo spettatore con una narrazione complessa.
Si trasforma, quindi, anche il ruolo del pubblico. Improvvisamente reso corresponsabile della costruzione di senso, chiamato a un lavoro di ricerca, decifrazione e disvelamento di significati complessi e nascosti. Oggi è la norma, con il coinvolgimento del fandom in un gioco ermeneutico diffuso (poi codificato da Lost). All’epoca era una novità.

E poi, naturalmente, c’è il tema del tono e del linguaggio. Lo spettatore capisce molto presto che dovrà essere disponibile a vivere una molteplicità di reazioni diverse, persino opposte, che cambiano nell’arco di pochi secondi. Letteralmente fin dall’inizio. C’è un corpo sulla spiaggia: tensione. La segretaria della stazione di polizia si dilunga in una incredibilmente minuziosa e nevrotica descrizione del telefono su cui dirotterà la chiamata per lo sceriffo: comicità. Lo sceriffo scopre il cadavere e identifica la vittima: angoscia, emozione. Il vice-sceriffo scoppia a singhiozzare perché non sopporta la vista di un morto: straniamento.
Lo stesso avviene con l’introduzione di molti personaggi iconici della serie, nel corso della prima puntata, spesso segnati da attributi bizzarri. E ovviamente con l’ingresso in campo del più iconico di tutti, l’eroe, l’agente speciale dell’FBI Dale Cooper. Che fin dalla prima apparizione, a circa 30 minuti dell’episodio pilota, mostrato mentre guida in direzione della cittadina di Twin Peaks, è caratterizzato da idiosincrasie ed eccentricità: il registratore audio a cui detta alla misteriosa Diane appunti e annotazioni a volte peregrine, l’appassionata curiosità per gli alberi della zona che gli appaiono maestosi e particolarmente profumati, il piacere quasi ossessivo per una buona fetta di torta di ciliegie e una tazza di caffè nero e fumante.
Una rivoluzione, dicevamo, nel panorama televisivo dell’epoca. E come se non bastassero gli aspetti di innovazione formale, strutturale, linguistica, la stessa storia si rivelò molto presto fonte di sorpresa, confusione, meraviglia. Perché in Twin Peaks c’è un delitto, e c’è un detective: e fin qui, diciamo, tutto bene. Ma per chi si aspettava che almeno l’indagine procedesse in modo ordinario, una sconcertante sorpresa andava preparandosi.
Minare ogni certezza: Zen, or the Skill to Catch a Killer (Twin Peaks episodio 3, stagione 1).
È solo alla terza puntata della prima stagione che la serie mostra pienamente ciò di cui sarebbe stata capace. Con l’episodio intitolato Zen, or the skill to catch a killer, che cambierà la tv in modo duraturo. Accade attorno a due movimenti, uno narrativo e uno meta-narrativo. Il movimento narrativo è l’ingresso in scena di personaggi e forze sovrannaturali, con una complessa collocazione ontologica che fa virare la serie verso una dimensione del tutto inusuale. Il secondo movimento, quello meta-narrativo, è dato dalla messa in crisi, con una intensità quasi parodistica, del modello classico di investigazione, il giallo tradizionale.
Tra le molte innovazioni di Twin Peaks, una delle meno sottolineate è paradossalmente una delle più visibili: e cioè l’aver dato una robusta spallata al modello imperante di detective story, e di detective. Un modello che aveva sostanzialmente retto per un secolo, dalla creazione della figura iconica dell’investigatore moderno: Sherlock Holmes. Lo schema delitto / indagine razionale / soluzione, intrinsecamente soddisfacente per il lettore (o spettatore), resisterà a infiniti mutamenti socio-culturali e mediatici, prosperando in particolare proprio in televisione: dove il modello di un caso che si apre e in 45-50 minuti si chiude si sposa da un lato con i tempi commerciali del medium, dall’altro con la sua intrinseca vocazione alla rassicurazione di un pubblico eminentemente domestico.
Nel pilota e nella puntata successiva, ancora regge la forma di una investigazione tradizionale: bizzarra, certo, ma non sovversiva. Ma poi le strade, rispetto al modello classico, si separano. E nettamente. Siamo solo alla terza puntata e troviamo una memorabile scena in cui l’investigatore spiega agli attoniti rappresentanti locali delle forze dell’ordine il suo peculiare metodo d’indagine: un metodo zen e di ispirazione tibetana che fonde subconscio e coordinamento fisico, e che consiste nello scagliare un sasso per ogni nome di un possibile sospetto: se il sasso centrerà una bottiglia, quella è la persona che dovremo andare a interrogare. Non basta? Questo metodo, dichiara tranquillo Cooper, l’ho derivato da un sogno.

Se da un punto di vista meta-narrativo Twin Peaks smonta in pochi passaggi un modello secolare, così lasciando ancora più in confusione il proprio pubblico, non di meno fa dal punto di vista narrativo. Di nuovo ricorrendo al sogno. E lo fa nella medesima puntata, che non per caso definivamo un momento di svolta sia nella serie che più in generale nella serialità televisiva moderna. Siamo agli ultimi minuti dell’episodio. L’agente Cooper si addormenta. E sogna.
Sogna un uomo con un braccio solo che si svela essere una sorta di potenza ultraterrena. In conflitto con un’altra entità, che ha un nome ordinario (Bob!) e un aspetto da hippy stagionato ma è una forza maligna che insidia il mondo. Il sogno cambia. Ora Cooper è nella metafisica Loggia Nera, un non-luogo fuori dallo spazio e dal tempo, connesso con il nostro mondo. Un nano vestito di rosso inizia a ballare. Laura Palmer, la ragazza morta dal cui assassinio tutta l’indagine è partita, sussurra qualcosa all’orecchio di Cooper. L’agente si sveglia, convinto di conoscere l’identità del killer; salvo averlo dimenticato la mattina dopo.
Smontando dalle fondamenta le collaudatissime formule del genere di intrattenimento televisivo per antonomasia, il giallo, e introducendo potenti elementi sovrannaturali all’interno di una detective story in forma di soap opera, la tv poteva compiere un gesto apertamente sovversivo: smettere di essere rassicurante. Quanto alla soluzione del delitto, caposaldo del modello investigativo classico, inutile dire che non era di primario interesse per Lynch. Come meglio vedremo nella prossima puntata.

Il non più così piccolo schermo: Lonely Souls (Twin Peaks episodio 7, stagione 2)
Facciamo un discreto salto avanti. La prima stagione dello show è finita, salutata da un successo planetario enorme e inatteso. Tutto bene? No. Il pubblico, che solo in parte ha compreso la portata rivoluzionaria della serie, scalpita: vuole sapere chi ha ucciso Laura Palmer, come domandavano le pubblicità dell’epoca. La produzione vuole accontentarlo. Lynch, da parte sua, fatica a gestire il successo, ha già un impegno cinematografico in agenda (Wild at Heart, 1990), ma soprattutto non ha nessuna leva contrattuale con ABC.
La seconda stagione di Twin Peaks si sviluppa così, dopo un inizio promettente firmato da Lynch, sotto gli auspici forse peggiori. Con i propri autori marginalizzati, assenti per gran parte delle riprese. La smania di sfruttare il più possibile il successo del primo capitolo. Le pressioni del pubblico. Negli anni successivi, gli autori TV vedranno un considerevole aumento del proprio controllo creativo (fin da I Soprano, l’altra serie “genitrice” della serialità moderna). Ma all’epoca non era così. La seconda stagione sarà lunga 22 episodi, ma i produttori hanno fretta: l’assassino deve essere rivelato, è deciso, già alla settima puntata.
Lynch e Frost dissentono: per loro il disvelamento del killer non è affatto l’obiettivo. Casomai, l’indagine sull’omicidio è un pretesto: l’occasione per entrare in un micro-cosmo, quello della quieta cittadina di provincia, scavarvi, e scoprirne i fantasmi, i peccati, le profonde inquietudini che si celano dietro la facciata perbene. Fosse per loro, lo sapremo dalle successive interviste, il killer probabilmente non verrebbe affatto svelato. Lynch lo dirà apertamente: “C’era spazio per così tanti misteri. Ma quel mistero (la morte di Laura) era sacro e teneva in piedi tutti gli altri. Era l’albero, e gli altri misteri i rami”.

Per la puntata fatale Lynch torna alla regia; Frost alla sceneggiatura. Insieme, i due congegnano una trappola ardimentosa: da un lato, daranno alla rete ciò che la rete pensa il pubblico voglia; dall’altro, proveranno a renderlo irrilevante. L’assassino si rivela; allo stesso tempo, non ha più molta importanza. La parte finale di una puntata tesa e magistrale, che resta negli annali di quella televisione che poi avremmo imparato a chiamare complessa, è un manifesto della poetica lynchiana sulla sacralità del mistero, e al contempo lo sberleffo di un autore che ha perso il controllo della propria creatura ma ancora, per un attimo, prova a guidarla.
Spinto da un presagio, l’agente Cooper va con lo sceriffo e l’oracolare Signora Ceppo alla Roadhouse, il locale notturno di Twin Peaks. Mentre gli eroi bevono una birra e mangiano noccioline, altrove il Male torna a manifestarsi. Proprio nella casa di Laura Palmer, Bob uccide ancora, attraverso il proprio veicolo umano, che quindi ci viene rivelato.
Ma scoprire chi avesse ucciso la ragazza non è più così importante: il Mistero si è spostato altrove. L’atmosfera del night club è ora completamente mutata: una malinconia che sfocia nella disperazione si è impadronita di tutti i personaggi, e la puntata termina sulle note evocative e struggenti di una canzone d’amore.
E così, con un sovvertimento tipico di Lynch, la soluzione del mistero – architrave di ogni cliché di genere – viene vanificata, additata come irrilevante. In questa puntata così sofferta si registra la terza grande innovazione dello show. Costretti a fare i conti con il conformismo produttivo del tempo, gli autori realizzano nella parte conclusiva di quest’episodio un gioiello visivo e narrativo che grida al pubblico: dimenticate le regole, dimenticate le aspettative, ciò che conta non è la spiegazione ma il mistero.
Twin Peaks rivendicava così per la prima volta nell’epopea della TV un diritto: quello di non accontentarsi di raccontare piccole storie con un inizio e una fine, meglio se nei confini dei canonici 45 minuti, ma di indagare a piene mani il lato oscuro della mitologia Americana. Quel brulicare di creature normalmente invisibili al di sotto della patinata e ordinata superficie del mondo con cui si era aperto, quattro anni prima, Velluto Blu.
Di colpo, la TV poteva portare nei salotti domestici qualcosa che solo al cinema era stato prima concesso mostrare. L’inquietudine. Il perturbante. Che cosa questo significasse rispetto allo status del piccolo schermo non fu forse compreso subito; ma avrebbe cambiato quel medium per sempre.
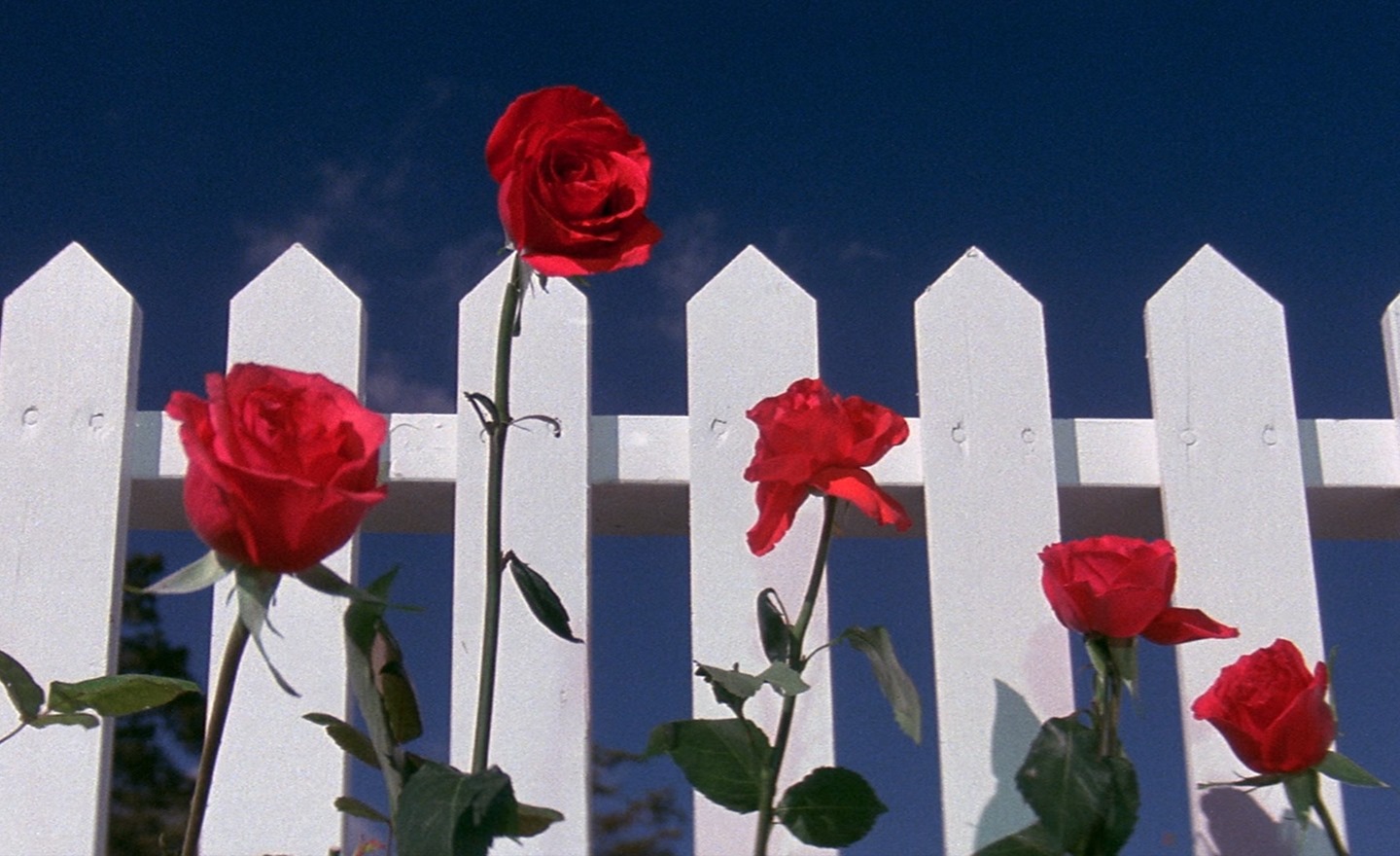
La tv come forma d’arte: Beyond Life and Death (Twin Peaks episodio 22, stagione 2)
È il giugno del 1991, e bisogna chiudere. Dopo la rivelazione del killer di Laura Palmer l’interesse del pubblico scema, gli ascolti calano, la serie arranca per altri 14 episodi, nessuno dei quali firmati da Lynch. Certo, è pur sempre Twin Peaks, e il tesoro di invenzioni, misteri, personaggi irresistibili ammassato dai suoi autori è tale che anche in mani mediocri resta un prodotto ben diverso da ciò che all’epoca passa in TV, a tratti ancora brillante. Ma è come se avesse perso la bussola.
Lynch, che è assente dalla puntata 7 della seconda stagione, torna per chiudere lo show: episodio 22, Oltre la vita e la morte. Sarà un addio o un arrivederci? Il regista ama profondamente la sua creatura, quel piccolo pezzo di mondo popolato di adorabili freaks. Avrebbe voluto continuare ad esplorarlo. Ma in quel momento sembra che non ci sia più spazio, quantomeno per il progetto radicale che aveva coltivato. Ma se chiudere bisogna – sembra essere il pensiero di Lynch – possiamo almeno chiudere in bellezza. Ed ecco una puntata conclusiva che non assomiglia a niente. Appassionata, visionaria, romantica, fiammeggiante, dolente, psichedelica, terrificante, spiazzante, commovente.
Cooper entra finalmente nella Loggia Nera, luogo senza coordinate di spazio o di tempo, nastro di Möbius di stanze uguali e diverse, collegate da corridoi e sipari rossi. Vi incontra le creature ultraterrene che in precedenza aveva sognato, o intravisto in forma allucinatoria: il nano e il gigante, il malefico Bob. E i doppelgänger: Laura Palmer (che profetizza, con notevole preveggenza metanarrativa: “Ci rivedremo tra 25 anni”); la di lei cugina, identica e identicamente assassinata; l’ambiguo padre della sfortunata ragazza; il suo ex partner all’FBI e ora avversario, Windom Earle; Annie, la donna che sta cercando di salvare.
E infine incontra se stesso, o meglio il proprio doppio negativo. Ed è in questa forma, con il Male (Bob) entrato in lui, che Cooper – il Cooper negativo – esce alla fine dalla Loggia.
Proprio quando era difficile pensare che lo show avesse ancora fiato ed energia, Lynch trascina la sua creatura a tagliare altri due traguardi storici.
Da un lato costruisce un finale (di puntata, di stagione e, per moltissimo tempo, di serie) che è la quintessenza del finale aperto. Un finale che non risolve, alimenta nuove domande e costringe lo spettatore a interrogarsi attivamente sul suo significato. Cosa che gli appassionati dello show faranno letteralmente per decenni.
Dall’altro lato abbatte l’ultima barriera e mostra che la TV poteva ormai ambire ad essere, senza sudditanze, un medium pienamente artistico, come abbiamo raccontato in questa puntata del podcast.

Twin Peaks aveva prodotto innovazione espressiva e narrativa, formale e strutturale. Aveva smontato le regole del medium televisivo e del genere a cui in teoria doveva appartenere. Aveva svelato l’esistenza di un’audience matura e dato vita allo spettatore moderno, non più passivo ma pienamente coinvolto nella costruzione di significato. E aveva sdoganato in TV categorie come quelle dell’inquietudine e del perturbante.
Ora, con il suo magnifico e impossibile finale, Twin Peaks mostrava senza ambiguità ciò che aveva fatto intuire fin dal principio: in TV si poteva produrre arte, non solo intrattenimento.
La televisione d’autore, e più in generale la complex tv, nascono qui. Show come prima X-Files e I Soprano e poi Lost non sarebbero neppure stati immaginabili senza Twin Peaks. E così, nel tempo, l’influenza della serie di Lynch si avverte distintamente in infiniti prodotti: Fringe, The Leftovers, Breaking Bad; Black Mirror, Mr. Robot, Dark; Fargo, True Detective.
Un’eredità feconda, che dall’originalità porta alla complessità e infine alla libertà.
Quella libertà autoriale che Lynch non riuscì pienamente ad avere nel 1990, complici le pressioni produttive e il clima restrittivo della televisione d’epoca. Ma che potrà rivendicare e mettere a frutto 25 anni dopo, nel 2017, con il terzo insperato capitolo della serie.
Di Twin Peaks: The Return Lynch firma così tutte le 18 puntate, come creatore, regista, co-sceneggiatore.
Dando vita a un’opera d’arte totale, nuovamente capace di inventare, innovare, meravigliare.
Ma questa, come si dice, è un’altra storia.
Twin Peaks: David Lynch e il trionfo della libertà | PODCAST
___________________________
Una precedente versione di questo articolo è stata pubblicata da Doppiozero il 7 aprile 2020, con il titolo Trent’anni di Twin Peaks


















