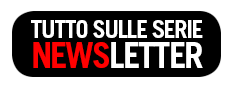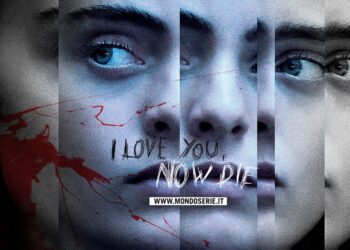Severance (in italiano: Scissione) è un thriller di fantascienza metafisica che in sole due stagioni ha surclassato tutte le altre produzioni di Apple TV+. Conquistando uno status pressoché immediato di serie cult.
Creata da Dan Erickson e prodotta con entusiasmo da Ben Stiller (anche regista principale), ha visto una prima folgorante stagione di 9 episodi nel 2022. Ci sono poi voluti tre anni per arrivare all’attesissima seconda stagione (10 episodi diffusi da inizio 2025).
Nonostante l’accoglienza entusiastica da parte della critica e del pubblico (di nicchia) di Apple TV+, Severance ha raccolto fin qui meno riconoscimenti di quanto ci si aspettasse. Un Peabody, qualche premio delle associazioni dei critici, ma nessuno dei premi maggiori. Alla 74ª edizione degli Emmy la serie ha ricevuto per la sua prima stagione ben 14 nomination, di cui 7 nelle categorie principali: tra queste, come miglior serie drama e per le formidabili interpretazioni di Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro e Christopher Walken. Ma si è dovuta accontentare di due premi tecnici, per la miglior sigla (meritatissima!) e la colonna sonora.
Certo, era l’anno (2022) dominato dalla terza stagione di Succession. Ma nella categoria delle serie drammatiche Severance è uscita sconfitta anche contro Squid Game (regia e attore protagonista). E questo è un po’ più difficile da accettare.
Segno che, probabilmente, il nostro show era troppo dirompente – o troppo in anticipo sui tempi.
Di cosa parla Severance, e cos’è la scissione
Severance ci trasporta nell’inquietante universo Lumon, un’azienda di biotecnologia detentrice di un nuovo metodo per rendere massimamente produttivi i suoi dipendenti. Un metodo chiamato appunto “severance”, ovvero, scissione, a cui alcuni impiegati si sono sottoposti volontariamente prima di entrare nella corporation.
L’operazione consiste nell’impianto di un chip elettronico nella testa del lavoratore. Al mattino, appena messo piede in azienda, il microchip dissocia completamente la vita personale da quella lavorativa. L’impiegato di Lumon nulla ricorderà della sua famiglia, amici e problemi esterni e sarà totalmente concentrato sui suoi compiti e sull’interazione con i colleghi. A fine turno, l’ascensore di uscita sancirà il ritorno della personalità “originale”, che nulla sa delle 8 ore appena concluse.
Ogni persona che si è sottoposta a scissione è inevitabilmente doppia: esistono un “interno” e un “esterno”, accomunati solo dal corpo. E nessuno sa niente dell’altro. Uno sdoppiamento totale di personalità diviso nell’arco della giornata e apparentemente senza rischi. Tuttavia le domande etiche sorgono spontanee. Vale davvero la pena sopprimere una parte di sé per far vivere un ‘lavoratore perfetto’? Che fine fa la libertà di azione se per otto ore al giorno si viene imprigionati in un mondo senza possibilità critica?
La scissione è senz’altro una scelta estrema, a cui si sottopongono individui dalla vita esterna complicata. Molte sono le motivazioni che hanno spinto i personaggi che animano gli uffici di Lumon a interrarsi in un lavoro coatto e perpetuo. Il protagonista Mark S. (Adam Scott, già nel cast principale di Parks and Recreation) si è fatto scindere per dimenticare, almeno per otto ore al giorno, la tragica morte della moglie. Il suo collega Dylan (Zach Cherry) non riusciva a trovare altri impieghi in grado di mantenere i suoi tre figli.
Una satira spietata della dissociazione lavorativa
Singolare che il termine “severance” in inglese si usi perlopiù figurativamente per indicare un ‘licenziamento’ dal posto di impiego. Lumon utilizza invece questo termine al contrario. La scissione è un sistema rivoluzionario che permette all’impiegato di non licenziarsi mai perché l’operazione sostenuta impedisce alle motivazioni private di contrastare gli oneri lavorativi.
Il creatore della serie, Dan Erickson concepì il soggetto in un periodo di depressione, mentre lavorava in un ufficio: trovava quel lavoro talmente monotono da desiderare di poter “saltare direttamente otto ore della giornata lavorativa, dissociarsi e farla finita”.
La serie è spesso interpretata come una denuncia al capitalismo e alle aziende dagli impiegati simili a robot, sfruttati e spesso poi rigettati senza nessuno scrupolo. Lo stesso Erickson conferma questa definizione: “Severance è nata da questo. Ai dipendenti si chiede sempre di dare e dare ancora, con la scusa che si fa parte di una famiglia – che lo si fa per amore – ma questo amore, spesso, non viene restituito in alcun modo concreto da parte dei datori di lavoro”.
I segreti della Lumon e le influenze orwelliane di Severance
Scopriamo nel corso delle puntate e delle stagioni di Severance che Lumon è molto più di un’azienda: fondata nel 1865 da un leggendario patriarca di nome Kier Eagan, la corporation ha un’identità talmente forte da sfiorare il totalitarismo. L’uso di un neolinguaggio simile a quello ipotizzato da Orwell in 1984 rinforza la sensazione di trovarci all’interno di un meccanismo atto alla distruzione del singolo individuo. Lumon non chiede solamente la sottomissione totale del dipendente: vuole la sua stessa esistenza. O almeno la metà di essa negli orari d’ufficio. Sul posto di lavoro il soggetto deve essere totalmente devoto alla causa. Come in 1984, dove il potere non si accontenta di imporre il “tu devi” ma vuole arrivare al “tu sei”.
Infarcito di simboli e leggende sul suo creatore, l’Universo Lumon è in continua e misteriosa espansione: nessuno dei dipendenti sa cosa succede negli altri piani dell’industria. Ognuno resta relegato al suo compito e ai suoi colleghi di reparto. Tutti supervisionati da dei capi dal sorriso sardonico, pronti ad elargire premi incomprensibili e punizioni alla minima infrazione.
Il settimo piano è il cuore narrativo della serie: lì i nostri protagonisti Mark S. (Scott) Helly (Britt Lower), Irving (John Turturro) e Dylan (Cherry) passano le loro giornate a ordinare numeri sui loro schermi, senza sapere perché. Devono raggruppare cifre ‘che fanno paura’ fino ad ottenere dei punteggi grazie ai quali riceveranno assurdi premi. Come cappellini da festa, esperienze danzanti e uova sode.
Al piano superiore, i loro capi, Mrs. Cobel (Patricia Arquette), nella prima stagione poi rimpiazzata nella seconda dal suo assistente Mr. Milchick (un eccezionale Tramell Tillman), non se la passano meglio. Vessati a loro volta da altri capi, premiano e puniscono i dipendenti seguendo un codice rigidissimo.
1984: l’incubo distopico diventato archetipo culturale
Loi abbiamo citato e ha quindi senso parlarne velocemente, anche per sottolineare i suoi collegamenti con Severance. Pubblicato nel 1949 da George Orwell, 1984 è uno dei romanzi più celebri e influenti del Novecento. Nato all’indomani della Seconda guerra mondiale, in un’Europa segnata dalla fine dei totalitarismi ma ancora immersa nella Guerra Fredda e nei suoi incubi ideologici, il libro è un’allegoria cupa e potentissima sulla sorveglianza, la repressione e la manipolazione del pensiero. Il titolo rimanda a un futuro allora prossimo, ma la sua forza simbolica ha attraversato i decenni, facendo di 1984 un riferimento imprescindibile per chiunque voglia raccontare, oggi, le derive del potere.
La trama segue Winston Smith, impiegato del “Ministero della Verità” nell’immaginaria Oceania, uno dei tre grandi super-Stati in guerra perenne tra loro. In un mondo dove il Partito dominante riscrive la realtà, cancella il passato e sorveglia ogni individuo attraverso il “Grande Fratello”, Winston tenta una silenziosa ribellione, mossa dal desiderio di libertà e verità. Ma nella società orwelliana anche il pensiero può essere reato: è il “crimethink”, il pensiero deviante, punito dal “Ministero dell’Amore”.
Romanzo sulla paura, sulla manipolazione linguistica (la celebre “neolingua”), sulla cancellazione della memoria e sulla distruzione dell’individuo, 1984 è diventato un archetipo culturale. Espressioni come “Grande Fratello”, “polizia del pensiero” o “doppio pensiero” sono entrate nel lessico comune. Ma più ancora del linguaggio, è la visione orwelliana a restare viva: la percezione che il potere cerchi non solo di governare i corpi, ma di controllare le menti.
1984 continua a ispirare film, serie e riflessioni contemporanee. Anche Severance, con il suo ufficio claustrofobico, la divisione tra io pubblico e io privato, e la volontà di rendere l’individuo docile e “funzionale”, parla in fondo la lingua di Orwell.
L’estetica di Severance, tra uffici, computer, cibo
“Se si scava fino in fondo, in Lumon tutto è una punizione. Per questo volevo una scenografia fredda, brutale, disumanizzata”, ci dice sempre Erickson. L’estetica è uno dei punti di forza della serie. Influenzati dai corridoi metafisici di Twin Peaks e dalle visioni impossibili di M.C.Escher, i creatori di Severance hanno lavorato per arrivare a vette di perfezione nel decor.
Il designer Jeremy Hindle ha combinato elementi architettonici e aziendali degli anni ’60, ’70 e ’80 citando l’architetto modernista Eero Saarinen come influenza per la progettazione degli edifici. Tutte le attrezzature da ufficio riportano il marchio Lumon. I designer hanno ricostruito vecchi computer con trackball funzionanti per permettere agli attori di compiere azioni verosimili e abituarsi all’ambiente. I terminali erano privi del tasto “Esc”, come metafora della mancanza di controllo che gli “interni” hanno negli uffici della Lumon.
Persino il cibo assume un valore diverso dalla realtà che conosciamo. “Ho cercato di trasformare il cibo in un personaggio vero e proprio” spiega al New York Times Catherine Miller, la “prop master” dello show. E in quanto personaggio, il cibo in Severance non è mai quello che sembra: come nelle prigioni, può servire da elemento di corruzione, umiliazione o premio. Per dei lavoratori che non conoscono altro che il loro computer e non vedono mai la luce del sole, anche un dolcetto può assumere proporzioni smisurate e significati occulti.
Nel corso delle due stagioni, diversi momenti epici legati al cibo scandiscono alcune giornate speciali. Il waffel party, dove un succulento e ‘brutalista’ wafer imbevuto di sciroppo d’acero ricompensa dei goal sconosciuti . O i marshmallows con la faccia del Kier Eagan, il patriarca, creati apposta per celebrare un’uscita di gruppo ma che vengono gettati nel fuoco per punire l’atteggiamento poco rispettoso dei dipendenti durante la lettura di un passaggio sul mito fondante dell’azienda.
Per non parlare dell’anguria scolpita con la faccia di Irvin, un impiegato che è stato licenziato. L’anguria antropomorfa viene usata alla sua commemorazione funebre in ufficio. E i suoi ex colleghi sono crudelmente invitati a mangiarsela.
Interni, esterni: desideri, paure, amore
Per i dipendenti il licenziamento, la scissione, significa una mezza morte: la fine dell’individuo scisso che hanno incarnato nel loro tempo lavorativo. Ritorneranno ad essere solamente un “esterno”. E per gli altri dell’ufficio è un decesso doloroso poiché non rivedranno mai più l’interno che è stato licenziato. La sua identità, la sua vita, verranno terminate.
Nel corso della seconda stagione scopriamo che gli interni e gli esterni possono essere molto diversi, pur condividendo lo stesso corpo. Addirittura, possono diventare nemici. E lottare per la stessa donna, come due rivali. O amare due donne diverse, lasciando entrambe ferite.
La domanda finale che pone la serie è: ogni “io” ha diritto ad amare, odiare, ribellarsi? O soltanto l’io “legittimo”, quello che ha una vita privata, una casa, dei figli e delle bollette da pagare? Sono quelli i problemi della vera vita, i veri amori, le vere speranze?
E, al contrario, il tempo passato in ufficio è solo un modo per pagarsi la vera vita al di fuori e l’“interno” non deve chiedere niente, perché riceve già quello che nutre il suo “esterno”? Oppure anche l’io che si sacrifica per il lavoro, che nasce e muore ogni giorno per un’azienda sadica che tende a mangiarselo, può avere emozioni, problemi e speranze?
Il finale enigmatico della seconda stagione che vede Mark S. e Ellie correre all’infinito per gli infiniti corridoi di Lumon ci lascia pensare che quell’io aziendale ancora non si dà pace, e continuerà a lottare per una vita propria. Con diritti ed emozioni da riconoscere e rispettare. Il protagonista, Mark S. ha scelto di restare un interno, rinunciando alla fuga. Perché? Ribellione ontologica? Masochismo ormai irreversibile? O semplicemente… amore?
Severance, verso la terza stagione
Il più grande nemico del totalitarismo è il singolo individuo, l’io che lotta per non essere massificato e controllato. Ma la lotta può essere accesa solo da un sentimento più forte della distruzione della volontà. Come in 1984, anche in Severance il protagonista combatte e si ribella grazie all’amore. Winston S. ama Julia, Mark S. ama Helly.
Il desiderio del loro “io” per un altro “io” abbatte ogni massa, ogni credo imposto, ogni dogma inflitto. Perché l’amore di un singolo per un altro singolo è una legge naturale che sfugge completamente al controllo del Grande Fratello – o di Kier Eagan.
Forse ci sarebbe piaciuto che Severance terminasse in questa corsa sfrenata dei due amanti per i corridoi, immortalati per sempre in uno dei tanti quadri di Lumon. Perché la straordinarietà di questa serie consiste nel moltiplicare le nostre domande e le nostre risposte, perse nei perfetti e sinistri simboli del suo universo. E nel concedere allo spettatore di credere nell’incertezza, nell’ignoto. Di lasciarlo oscuramente scrutare nella moltiplicazione di significati metafisici, poetici, di questa straordinaria serie tv.
Invece è arrivata la notizia di una terza stagione, che infiamma i milioni di devoti.
Ci auguriamo caldamente che il nostro affezionatissimo Mark S. non faccia la fine del Winston S. di “1984”.
Ti piacciono le workplace comedy? Leggi il nostro articolo su The Office!
The Office: i 20 anni di una grande satira dell’umanità al lavoro