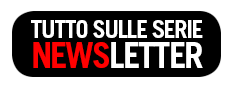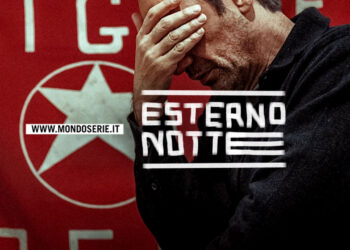Winston Churchill disse una volta che “gli italiani vanno alla guerra come se fosse una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come se fosse la guerra”. La frase ha continuato a ronzarmi in testa per diverse puntate di M – Il figlio del secolo, l’audace miniserie televisiva che racconta in 8 episodi la genesi del fascismo e l’ascesa di Benito Mussolini (su Sky e NOW). D’altra parte, autore dello show è l’inglese Joe Wright. Che, guarda un po’, nel suo ragguardevole portfolio registico ha lo splendido affresco appunto sul Churchill nel pieno della Seconda Guerra Mondiale: L’ora più buia.
La citazione mi perseguitava con un misto di emozioni. Divertimento, perché – specie nei primi episodi – è innegabile l’emergere potente di un lato ridicolo, grottesco, persino comico nel racconto di quegli anni. Le pose, il linguaggio, l’abbigliamento, e poi D’Annunzio, la retorica, il re Sciaboletta… Preoccupazione, perché avevo una maledetta paura che la serie finisse fuori strada, fallendo una missione difficile e trasformando la complicatissima materia in farsa; o, peggio, producendo (involontariamente) una sorta di umanizzazione empatizzante del dittatore, potenzialmente pericolosa in tempi di rincretinimento di massa. E diciamo che qualche momento un po’ troppo spregiudicato (il Mussolini che proclama “Make Italy Great Again”, per dirne uno) poteva far temere il peggio.
E infine angoscia. Cioè, in fondo, il sentimento giusto nell’assistere a un racconto che con straordinario coraggio si proponeva non solo di illustrare pagine complesse, difficili, problematiche, ma anche di trasformare la vicenda storica in apologo morale. Riflessione sul tempo presente. Monito sui corsi e ricorsi dell’umana tragedia.
Per fortuna, in M – Il figlio del secolo il coraggio si accompagna a una mirabile maestria. Dando vita a una miniserie in cui tutto funziona perfettamente, anche nell’apparente eccesso di una messa in scena giustamente funambolica.
M – Il figlio del secolo: un’ambiziosa produzione internazionale
Basata sull’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, M – Il figlio del secolo è una coproduzione italo-francese di eccezionale ambizione. Sia per l’importanza del tema storico trattato – la nascita del fascismo – sia per l’alta qualità artistica e tecnica. Realizzata da Sky Studios in collaborazione con Pathé, The Apartment e Kavac Film, la serie è diretta da Joe Wright, regista britannico noto per film di grande impatto come Espiazione e appunto L’ora più buia. Ed è ottimamente scritta da Stefano Bises e Davide Serino, già sceneggiatori dell’eccellente Esterno notte. Di Wright e del ciclo di romanzi parliamo meglio dopo.
Il ruolo di Benito Mussolini è affidato a Luca Marinelli, attore di straordinario talento (un titolo su tutti: Lo chiamavano Jeeg Robot). Qui costretto a ingrassare di una ventina di chili, rasarsi il capo, sottoporsi a cospicue sedute di trucco – e, a giudicare da certe sue interviste dopo l’uscita, rischiare l’esaurimento nervoso per il carico emotivo dell’intenso e sgradevole ruolo.
Composta da otto episodi, la miniserie segue l’evoluzione politica di Mussolini dagli anni immediatamente successivi alla Prima guerra mondiale fino al delitto Matteotti del 1924. La cui rivendicazione da parte del Duce – con un famigerato discorso al Parlamento – segna la definitiva trasformazione del fascismo in dittatura assoluta. Presentata in anteprima al Festival del cinema di Venezia, uscita con molto successo nel gennaio 2025 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, vedrà nei mesi successivi una distribuzione estera.
M – Il figlio del secolo si distingue nettamente, anche per la caratura internazionale, dagli standard produttivi italiani. Condizione necessaria per raccontare uno dei periodi più bui della storia patria, e per farlo con la dovuta profondità. Rendendo anche giustizia ai romanzi di cui è una traduzione piuttosto fedele.
Antonio Scurati e la serie di “M”
L’opera da cui è tratta la miniserie, M. Il figlio del secolo, è il primo volume di una serie scritta da Antonio Scurati, studioso e narratore esperto nel raccontare le dinamiche del potere e della violenza nella storia. Pubblicato nel 2018 e vincitore del Premio Strega 2019, il libro ha riscosso un successo enorme, diventando un vero e proprio caso editoriale.
Scurati, nato a Napoli nel 1969, ricercatore e poi docente universitario, è autore di numerosi saggi e romanzi. Il lavoro che lo rivela al grande pubblico, nel 2005, è il tesissimo e inquietante Il sopravvissuto (Premio Campiello), ispirato a certi clamorosi massacri scolastici americani. Con la serie di M Scurati ha raggiunto un impatto senza precedenti, trasformando la ricostruzione storica in una narrazione avvincente e accessibile a un vasto pubblico.
Il primo volume copre gli anni 1919-1925, raccontando la nascita del fascismo e il progressivo consolidamento del potere da parte di Mussolini, culminando con l’omicidio Matteotti. Il secondo libro, M. L’uomo della provvidenza (2020), approfondisce il consolidamento del regime fascista tra il 1925 e il 1932, analizzando la trasformazione di Mussolini in dittatore assoluto. M. Gli ultimi giorni dell’Europa (2022) affronta gli anni cruciali che portano alla Seconda guerra mondiale, mentre il successivo M. L’ora del destino ci porta fino al crollo del regime, nel luglio 1943. Il quinto e ultimo volume uscirà quest’anno in una data simbolica: il 25 aprile, Festa della Liberazione.
L’adattamento televisivo si concentra sul primo volume, offrendo una rappresentazione visiva dell’ascesa del fascismo che riprende lo stile narrativo del libro: un mix tra documentazione storica e romanzo, in cui la cronaca dei fatti è filtrata attraverso la soggettività dei protagonisti. L’obiettivo: trasmettere quella sensazione di inevitabile catastrofe che permea l’opera originale.
Il periodo storico: dalla nascita del fascismo all’omicidio Matteotti
Gli eventi narrati in M – Il figlio del secolo coprono un periodo di grande instabilità per l’Italia, quello successivo alla Prima Guerra Mondiale. Un’epoca segnata dalle tensioni sociali, dalla crisi economica e dalla violenza politica. In questo contesto, Benito Mussolini, ex socialista rivoluzionario e direttore prima dell’Avanti! e poi de Il Popolo d’Italia, fonda nel marzo 1919 i Fasci Italiani di Combattimento, un movimento che mescola elementi nazionalisti, populisti e violenti.
Attraverso un uso strategico della retorica e della forza, e grazie anche alla debolezza del sistema dei partiti tradizionali, Mussolini riesce a trasformare il fascismo da un piccolo gruppo marginale di estremisti revanscisti in una forza politica dominante. Il grande bluff della Marcia su Roma del 1922, raccontato dalla serie con accenti grotteschi, segna il momento decisivo: il re Vittorio Emanuele III, temendo una guerra civile, concede a Mussolini l’incarico di formare un governo, legittimando così definitivamente il fascismo.
La serie segue questi eventi con accuratezza, mostrando il ruolo degli squadristi, le violenze contro socialisti e sindacalisti, il sostegno crescente della borghesia industriale e l’incapacità dei partiti tradizionali di fermare l’ascesa del dittatore. L’omicidio Matteotti nel 1924 rappresenta il punto di svolta: il deputato socialista denuncia i brogli elettorali e la violenza fascista alle ultime elezioni, vinte dal Listone. Verrà rapito e assassinato dai sicari del regime. Nel 1925, in Parlamento, Mussolini assume pubblicamente la responsabilità politica della violenza fascista e dello stesso delitto. L’Italia diventa una dittatura assoluta.
M – Il figlio del secolo non si limita a raccontare, con un po’ di licenze, i fatti, ma esplora le emozioni dei protagonisti e lo spirito del tempo. Rendendo evidente come il fascismo non sia stato un destino inevitabile, ma il risultato di precise azioni. E forse soprattutto di inazioni.
Joe Wright e l’audacia stilistica di M – Il figlio del secolo
Alla regia di M – Il figlio del secolo troviamo, vero e pieno autore della serie, Joe Wright, cineasta britannico capace di coniugare spettacolo visivo e introspezione psicologica. Nato a Londra nel 1972, Wright vanta un bel catalogo di (acclamati) film. Con una particolare attitudine a tradurre in immagini fonti letterarie sia classiche che contemporanee: Orgoglio e pregiudizio (2005), il bellissimo Espiazione (2007, dal romanzo di McEwan), Anna Karenina (2012), Cyrano (2021).
Nel nostro cuore, però, un posto speciale ce l’ha L’ora più buia (2017). E non solo perché è il film che è valso l’Oscar al grandissimo Gary Oldman (che, in tv, tanto amiamo in Slow Horses). In Darkest Hour Oldman diventa Winston Churchill, raccontato in un momento cruciale della sua leadership politica: quando deve vincere le tensioni interne alla scena politica britannica e guidare una nazione stremata a resistere alla furia nazista.
Anche prima di M – Il figlio del secolo, dunque, Wright aveva mostrato una predilezione per i personaggi complessi e le ambientazioni storiche. E dato prova di uno stile personale e autoriale, in parte ispirato al “cinemone” di David Lean, in parte pittorico, in parte capace di invenzioni assai moderne. Così, la sua attenzione all’uso della luce e ai movimenti lunghi di camera qui si fonde a momenti espressionistici, sincopati, da videoclip (o quasi rave).
Non per caso avendo chiamato a comporre l’essenziale colonna sonora, efficacemente anacronistica, Tom Rowlands dei The Chemical Brothers, storico duo britannico di musica elettronica. Ed è proprio grazie a uno stile curatissimo e audace, insieme spettacolare e introspettivo, velocissimo, dinamico, intenso, che la rappresentazione di Mussolini evita sia la trappola della caricatura che quelle del biopic. Evidenziando costantemente l’ambiguità del personaggio – e del tempo di cui fu figlio.
Quando il tiranno parla al pubblico: da Shakespeare a House of Cards
Una delle scelte più potenti e destabilizzanti di M – Il figlio del secolo è la costante rottura della quarta parete. Il Mussolini di Marinelli guarda in macchina, si racconta, si giustifica, si confessa, cercando di portare lo spettatore dalla sua parte. Non è solo protagonista, ma anche narratore della propria ascesa al potere, trasformando il pubblico in testimone attivo – quasi complice. La macchina da presa diventa il popolo, e chi guarda si ritrova coinvolto nel suo discorso.
Questa tecnica narrativa ha precedenti illustri. Riccardo III di Shakespeare è forse l’esempio più potente: il tiranno parla direttamente al pubblico, rivelando i suoi intrighi con un’eloquenza seducente. “I am determined to prove a villain,” dichiara all’inizio dell’opera, instaurando un rapporto ambiguo con lo spettatore, complice della sua sanguinosa scalata al trono. Lo stesso fa il Frank Underwood interpretato da Kevin Spacey in House of Cards: ci parla, ci prende in disparte, ci svela i suoi piani, ci coinvolge nelle sue strategie di potere. Spezzare la quarta parete non serve solo a raccontare, ma a sedurre.
In M – Il figlio del secolo, tuttavia, l’effetto è ancora più inquietante: Mussolini è una figura storica reale. Lo spettatore si trova a vedere il mondo attraverso i suoi occhi. È una scelta che obbliga chi guarda a un confronto scomodo: il racconto storico diventa un’esperienza immersiva nella violenza del potere. Il suo sguardo in camera obbliga noi spettatori a confrontarci con la forza della sua retorica, persino con il fascino osceno della violenza. Per questo, la serie non è solo un racconto storico, ma un’audace e insieme quasi pericolosa esperienza immersiva sulla seduzione del potere, che costringe lo spettatore a chiedersi: e io, al suo tempo, come avrei reagito?
Storia lontana o apologo attuale?
Riccardo III e Frank Underwood sono personaggi di fantasia. Mussolini no, ma è legato a un passato che nell’attuale tendenza all’oblio (o alla rimozione) di ciò che non è immediatamente presente rischia di sembrare lontano. Quasi favolistico. Mitico. E ovviamente indecifrabile storicamente, nella confusione cognitiva che ci attanaglia, ma solo sintetizzabile ideologicamente. In particolare per ovvie ragioni in Italia, dove l’erosione proveniente da molteplici fronti (il trascorrere del tempo, la cultura della disintermediazione digitale, il revisionismo anti-intellettuale e anti-culturale dei populismi) ha finito per riportare l’ex dittatore più o meno dov’era un secolo fa: una figura divisiva! Ed è questo il paradosso che M – Il figlio del secolo prova, assumendosi più di un rischio, a mettere in luce. La storia che racconta non è lontana, e forse neppure passata…
Ecco dunque il perché delle strategie attuate da Wright nello scegliere come raccontare la sua storia, cioè la nostra storia. Ecco il perché del parlare in camera del protagonista, delle sacrosante libertà storiche (contestate dai soliti soloni manco fosse un documentario), delle scelte stilistiche fortemente anacronistiche (musica, montaggio, messa in scena). Perché la narrazione dell’ascesa di Mussolini, pur vecchia di un secolo, finisce per illuminare il presente. Evidenziando dinamiche che trovano evidenti parallelismi nelle odierne crisi democratiche. E nella popolarità, nuovamente crescente, degli autoritarismi.
Guardiamoci attorno. In Europa, negli Stati Uniti, da noi. Ovunque, una crescente sfiducia nelle istituzioni alimenta il rafforzamento dell’opzione populista. I sistemi politici tradizionali si scoprono vulnerabili al risentimento collettivo che segna il nostro tempo, alla rancorosa e viscerale disinformazione diffusa dai nuovi media, all’ascesa di leader carismatici e polarizzanti che promettono soluzioni semplici a problemi complessi.
Esattamente il milieu sovreccitato ed esplosivo che M – Il figlio del secolo racconta.
M – Il figlio del secolo: il fascismo e noi
Sono temi cruciali, che abbiamo toccato spesso qui su Mondoserie: per esempio nella nostra riflessione sulla messa in scena dark della politica nel cinema e nella tv. In cui raccontiamo gli effetti reali, sul nostro immaginario e persino nelle nostre scelte collettive, di una rappresentazione a tinte fosche del potere e delle istituzioni che attraversa i generi e i decenni. Dalla paranoia anti-governativa di X-Files e 24 alla già citata House of Cards, da Scandal fino alle nostrane Suburra e 1992.
M – Il figlio del secolo ha l’enorme merito di costringerci a riflettere su queste dinamiche – e sulla loro attualità. Tenendoci gli occhi ben aperti davanti alle scene di violenza, anche brutale, elemento non degenerativo ma costitutivo della “rivoluzione fascista”. Ma soprattutto forzandoci a riconoscere la facilità con cui la combinazione di crisi economiche, tensioni sociali e leadership autoritarie porta una società a sacrificare le proprie libertà in nome di una promessa – spesso illusoria – di ordine e sicurezza.
Ma questa straordinaria serie inquieta per un’altra – dolorosa – ragione. Perché ci mostra i limiti della nostra immaginazione. Prendiamo il Mussolini del monumentale Marinelli. A volte assomiglia a Scarface, a volte persino al Pinguino (ma non quello anti-retorico di The Penguin: quello un po’ grottesco dei fumetti e di certe vecchie rese cine-televisive, pingue, goffo, con il cappello a cilindro, la redingote). Insomma: il regista e il suo eccezionale protagonista non nascondono i tratti ridicoli del dittatore. Anzi. E questo loro Mussolini fa ancora più paura proprio perché, oltre che spietato e abilissimo, è anche ridicolo. Fa paura che non l’abbiamo visto arrivare, che sia stato sottovalutato, che non sia stato preso sul serio. Pensateci: è esattamente quello che è accaduto in America con Trump.
Così, M – Il figlio del secolo mette in luce il difetto congenito della “casta” intellettuale: la superbia. Mescolata alla pigra inerzia delle istituzioni di ogni tempo. Non possiamo neanche immaginare che certi outsider possano forzare il sistema, fregarsene delle convenzioni, piegare tutto a una propria visione. Non ne intuiamo il potenziale di violenza reale, non ne vediamo il carisma, non ne capiamo l’appeal. Chi potrebbe prenderli sul serio? Chi potrebbe votarli? Dove vuoi che vadano? Guardali – sono ridicoli!
E così ci sorprendono – fino a che non siamo costretti a prenderli sul serio. Ma allora, di solito, è già troppo tardi.
Il racconto della politica al cinema e in tv: il nostro approfondimento